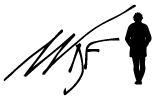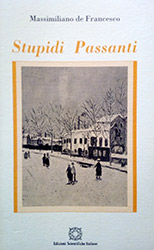Aveva gli anni di Cristo, parlava più lingue degli apostoli, scriveva poesie, recuperava sogni nei Sud del mondo, aveva il talento dell’inquietudine e il coraggio della libertà, attraversava terre dove gli occhi dell’inferno non chiudono mai le palpebre. C’era una volta Mario, Mario Paciolla, il piccolo vichingo del Rione Alto, il rematore di pace che seminava ideali, il progettista di speranze dalla camminata volante, con quel volto così dandy e scapigliato da farmelo sembrare sempre una rockstar in pausa concerto e in guerra con le visioni. Per caso, di notte, ho visto la sua chioma ramata in tv e ho appreso una notizia che fatico ancora ad accettare: «Volontario Onu italiano di 33 anni trovato morto in Colombia». E poi l’immagine del villaggio di San Vicente del Caguan, di una casa povera e senza colori, così lontana dai mari di Napoli e dal tepore di una madre, e ancora l’ipotesi del suicidio, assurda per chi ha “vissuto” Mario, e poi la pista dell’omicidio, il racconto delle ultime telefonate alla famiglia in cui diceva di voler tornare in Italia, lasciarsi alle spalle i tormenti di quei giorni, i litigi, la torrida paura di chi si sente braccato.
Tutta la sua favola mi si è aperta dentro, in una notte di zapping furioso contro le cronache del reale e l’assedio di congetture, tipico dei “casi” irrisolti che tanto fanno male. Perché quella di Mario, che mai sarebbe voluto essere un “caso”, era una favola in cui mi sono trovato a passare anch’io, una mattina lucente di oltre dieci anni fa, quando si presentò in redazione perché voleva diventare giornalista. Di fronte avevo un ventenne timido e scrutante, pronto alla scrittura e all’avventura. Iniziò a collaborare con i suoi pezzi “alla Chatwin” sia su Chiaia Magazine che su Iuppiternews, imparai a conoscerne a fondo l’integrità morale, la testa libera da faziosità e logiche di gretta appartenenza, la fierezza delle idee; m’innamorai della sua attitudine alla partenza verso posti del mondo che non vedrò mai e della bellezza dei suoi ritorni in redazione, sempre, come diceva lui, con un “pensierino del viaggio, una sciocchezza”, gesto di amicizia e di nobile riconoscenza per il tesserino di giornalista pubblicista che, mi confessò con un sorriso pieno, gli fu prezioso per mettere su altre redazioni ed entrare nella task force del Papa nella sua ultima visita colombiana.
Troppe cose belle spazzate via in una volta sola. Troppe. La promessa di una birretta appena saresti tornato, una passeggiata notturna carica di rivelazioni, un libro di viaggi e poesie su cui discutevamo da tempo, una partita di basket in un campetto di periferia dove mi avresti battuto, un viaggio in Andalucia che avrei voluto fare con te che già l’avevi conquistata in bici e raccontata in uno dei tuoi pezzi più belli, dal titolo Tutte le voci portano a Napoli, in cui scrivi: “A volte mi chiedo perché sono costretto ad andare fuori per amare la mia città. Perché non posso essere libero di ascoltare davanti Castel dell’Ovo il vecchietto paffuto col violino e cantare con lui davanti Santa Lucia o inneggiare a una bella giornata di sole”. E se è vero che la morte non colpisce i miti né i leoni, mi mancherai e ci sarai ogni volta che guarderò la bottiglia di ron che ci regalasti a Natale, tirandola fuori da sotto il tuo giubbino cinematografico come la colt di un pistolero di Leone, o quella foto che mi inviasti tempo fa, in cui con l’aria di Lennon, appagato nel verde, sei pronto ad andare col tuo zaino blu Chagall e quel fiore di sole che atterra ogni parola superflua.