Quando finisco un libro ho l’abitudine di segnarmi la data. L’8 agosto 2019, su un balcone cilentano, appena uscito dalla controra, lessi l’ultima pagina del romanzo Lavoro a mano armata, scritto da Pierre Lemaitre, storia di un disoccupato di 57 anni che fa di tutto pur di lavorare. Di tutto, sequestro compreso. «Non posso fare a meno di lavorare»: così si congeda Alain Delambre, antieroe che rifiuta l’esclusione, stratega irascibile d’un piano alla Dantès che, inevitabilmente, finirà per compromettere l’istituzione famiglia.
La miniserie di 6 episodi, tratta dal libro e vista su Netflix con inaudita voracità, è stata come un’irragionevole corsa su un caravan – mezzo di locomozione con ruolo risolutivo nella storia – che vorresti guidare fino allo schianto contro le ingiustizie che consegna l’abisso della precarietà. L’opera visiva che ne viene fuori è notevole per la scrittura di Lemaitre, che sui dialoghi mostra quanto sia decisivo il sigillo del ritmo, per la regia adrenalinica e appassionata di Ziad Doueiri, che con L’insulto ha fatto capire che sa dove piazzare lo sguardo nei conflitti interiori, per l’exploit dell’ex calciatore e attore gigantesco Éric Cantona, che si prende il pallone dalla prima scena e riesce a mantenerlo fino all’ultima con il furore del fuoriclasse. Delambre e Cantona sono la stessa persona: questo è il motivo per cui il “ruolo perfetto” è compiuto.
Quanto Delambre c’era in Cantona quando sferrò un calcio alla Bruce Lee al tifoso del Crystal Palace che lo riempiva d’insulti mentre usciva dal campo? Tanto. E quanto Cantona c’è nel Delambre che cambia le regole del gioco con la scioltezza del leader e si esibisce, prima dell’arresto, in un geniale “passaggio” al compagno di squadra Charles per vincere la partita contro la multinazionale Exxya e scipparle milioni di euro in modalità “esproprio proletario”? Tantissimo. Ken Loach, che di vite precarie se ne intende, affida un inno al passaggio proprio a Cantona nel film Il mio amico Eric, altra storia di sconfinamento negli Inferi e perdita di luce, in cui al protagonista, che senza successo fa a pugni con la realtà, non resta che invocare il mito del Manchester United, ultima chiamata per la salvezza. Cantona gli appare come un semidio dalla lampada in una scena stracult, spiegando che non è stato un gol il momento più bello di tutti ma un passaggio, un’azione che nessuno s’aspettava, una sorpresa figlia della fiducia che si ripone negli altri.
NEl film “il mio amico eric” Ken Loach affida a Cantona l’inno al passaggio
Delambre vive di “passaggi”, anche se sembra un giustiziere solitario: il suo stratagemma è attirare l’attenzione su di sé per smistare meglio le bugie, creare falsi obiettivi, distrarre l’avversario per costruirsi spazi di speranza e provare ad andare in gol con l’aiuto della squadra. Anzi, quasi all’insaputa della squadra. L’abilità che ha nel travestirsi da sconfitto, nel convincere gli altri che l’unica soluzione possibile è la sua e nel resistere alla detenzione – la serie pesca a piene mani nel genere prison movie che tanto garba ai piani alti di Netflix -, conferma che quest’uomo scende in campo avendo ben chiara una visione di gioco e aspirando a una condivisione del suo progetto di riscatto, della sua fame di vendetta. Seppur la storia si presenti a larghi tratti come la lettura di un manuale di manipolazione – emblematico l’episodio in cui Delambre vuole la figlia tosta ma inesperta come suo avvocato perché ne prevede un utile coinvolgimento emotivo in un processo già maneggiato in partenza – riesce a conservare la potenza disperata di un uomo fragile e ipercontemporaneo in guerra col sistema, costretto a umiliarsi per la paga, a subire l’umidità delle pareti di una casa incompiuta, a conteggiare rimorsi, a non reggere più gli occhi smarriti delle donne di famiglia, con la moglie Nicole che ne segue sgomenta e con amore instabile il cambiamento, la vertigine di violenza.
Nel libro Lamaitre usa la parola “egodissea” per battezzare il viaggio del suo Ulisse disoccupato, che desidera con tale rabbia l’uscita dal fallimento da mettere in conto anche lo smantellamento della sua Itaca. In Alain Delambre, che con Cantona lascia la letteratura ed entra in scena con il giusto smalto d’impetuosità e quel piglio di ordinaria follia tipico degli esclusi dediti alla rivolta, convivono il Dustin Hoffman di Cane di paglia di Sam Peckinpah, dove un professore si trasforma in implacabile difensore del focolaio, e l’Antonio Albanese dell’incompreso L’intrepido di Pupi Avati, storia del precario dei precari Antonio Pane che per sbarcare il lunario sostituisce chi, per motivi vari, deve assentarsi dal lavoro. Personaggi che agiscono nel campo dell’invisibile, considerati marginali, che nell’epicentro del punto di non ritorno, assediati da angherie, reagiscono e sorprendono pur di recuperare il senso della dignità. In Delambre prevale il cane di paglia, mentre sparisce del tutto il sorriso eroico di Pane contro le imboscate della vita. Nel romanzo arriva a dire: «Funziona così, il successo. Come una collana. Basta disfare il nodo e tutto si sfila. Anche il fallimento funziona così, lo so bene. Per risalire la corrente ci vuole un’energia del diavolo. O bisogna essere pronti a morire. Io posso contare su entrambe le cose».

La consapevolezza che la vita, per la guerra intrapresa, può essere persa è la molla non catalogabile che spinge il disoccupato di Lamaitre a oltrepassare la normalità, a rivoluzionare un’esistenza di vane attese. E pronto alla morte è anche l’amico Charles, dio generoso dal volto imponente di Bakunin e la voce dei poeti, la cui magia si apprezza di più nella versione letteraria. Un altro emarginato pieno di talento, un “diverso” dai dolori trattenuti e con un intatto desiderio di giustizia. Sarà lui il raccoglitore del passaggio finale e, per certi versi, il realizzatore di un gol decisivo.
C’è un’ordinanza urgente che chi ci governa sciaguratamente non farà mai, in cui una norma dovrebbe prevedere l’obbligo per i palleggiatori di numeri, i gestori di risorse umane, i politicanti del rimando e gli estensori di decreti, palesemente a digiuno di reale, di frequentare il cinema della precarietà. Così lontani dalle esigenze del paese, può darsi che l’artificio della fiction possa stimolarli a capire come gira il mondo vero. Non capiscono ancora, soprattutto in questi tempi spaesati e ingiusti, quanti Alain Delambre sono pronti a lasciare l’attesa e rischiare ogni cosa pur di sentirsi vivi. Riafferrare la dignità. E sono pronti a farlo non solo a mani nude.
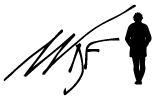








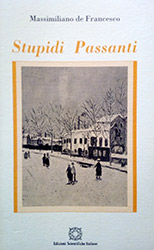
Quanto di Alain Delambre c’è in ognuno di noi, specialmente adesso, dopo un lock down surreale….
E’ proprio così… Delambre dorme in noi. E mai come in questi momenti è pronto al risveglio… Grazie per il commento. Maxxx